Il calore del sangue, romanzo perduto di Irène Nemirovsky, è costruito attorno a una scissione, anzi più di una. Numerose linee di frattura percorrono il testo. Si comincia con il narratore – che non è il protagonista, perché Chaleur du sang è un romanzo d’ambiente, dunque corale. Silvio o Sylvestre? È questione di prospettive. Il primo è un giovane partito all’avventura da un sonnacchioso villaggio della Borgogna. Il nome, come racconta lui stesso, è l’omaggio di una ragazza conosciuta in gioventù, convinta che somigliasse a un gondoliere. Quello che resta oggi del venditore di pelli in Canada, del funzionario in Congo, del commerciante di Tahiti è Sylvestre, un placido sessantenne convinto che si stia bene solo a casa propria, quando il “fuoco si placa”, “non gioca, non danza” ma “si accontenta di far bollire pian piano la pentola”.
Sylvestre è un osservatore della vita contadina, con i suoi placidi ritmi scanditi dal raccolto, le bestie, le carte, le feste, il vino, un tempo circolare riempito, in apparenza, di fatica e gioie semplici. Ancorché povero (ammette di aver dilapidato l’eredità paterna), Sylvestre sembra a proprio agio nel villaggio natìo in cui è tornato in tarda età, ma la maschera scivola via a mano a mano che procede nel racconto. La sua condizione di figliol prodigo mancato gli vale il disprezzo dei contadini, che pure frequenta alla taverna. “Fin dalle minime cose percepivo un malanimo dagli effetti prodigiosi, costantemente all’erta, calcolato per rendermi la vita insopportabile e costringermi a fuggire lontano. Ho resistito. Non me ne sono andato. Ma il mio patrimonio se lo sono preso loro”. Come Bloch in Perturbamento, anche Sylvestre ha scelto il proprio inferno privato in cui vivere.
C’è un prima e dopo nei romanzi di Nemirovsky. “Il caro, il dolce, il pio passato”, direbbe Micol Finzi-Contini, è la pietra di paragone in cui inciampano tutti i personaggi della sua comédie humaine. Il rimpianto per quel momento perfetto in cui “tutte le promesse giungono a maturazione e finalmente cadono i bei frutti” non è prerogativa solo dei vecchi. Persino la giovane Colette, figlia della cugina di Sylvestre, Hèléne, rimpiange la perfezione dei piaceri della propria infanzia.
Alla frattura temporale si affianca l’opposizione dentro–fuori. Le case di campagna sono confortevoli ma isolate, sbarrate da portoni massicci “come porte di prigione”. Le stanze sono affastellate di mobili e suppellettili, in una densità claustrofobica che contrasta con le vite degli abitanti, erose dal vuoto delle passioni. Fuori dai perimetri delle rispettive proprietà, il grande spettacolo del mondo è un perpetuo montaggio di nascite e morti intervallato da ellissi misteriose. Oltre le ultime case del paese, tra i campi silenziosi e i fitti boschi, accadono cose in cui è bene non immischiarsi troppo. Il mondo contadino è attento a preservare la buona forma, la decenza, ma sotto la coltre di una quiete spacciata per felicità ribollono gli istinti peggiori. Colette sposa il timido mugnaio Jean Dorin, ma finisce tra le braccia dell’ardente Marc Ohnet, a sua volta amante della trovatella Brigitte, figlia adottiva della sorellastra di Hèléne, Cécile. Brigitte è accasata con un vecchio avaro prossimo alla morte, ma al creatore ci finisce prima Jean Dorin. Gli tocca la stessa sorte di padre Péricand in Suite francese e Tat’jana in Come le mosche d’autunno: annegato. Sembra un incidente, invece dietro c’è la mano di Marc. È stato lui, in una colluttazione, a spingere il rivale nel fiume che scorre davanti casa.
Il calore del sangue è un romanzo di elementi. L’acqua, origine e destinazione ultima, liquido amniotico e tomba; la terra, dal costume locale confusa con gli uomini al punto da risultare indivisibile da essi; infine, il fuoco che brucia nelle vene. Confinata nel dominio capriccioso della gioventù, la passione dei sensi è una “febbre dell’anima” che agli occhi di Sylvestre appare come un delirio incomprensibile. Quando finisce, si fa fatica a ricordare. A Colette che gli confessa la verità sulla morte di Jean, il cugino risponde con un’ostentazione di freddezza. L’opposizione caldo-freddo torna spesso nel romanzo. Sylvestre avverte come un intorpidimento da cui si libera solo nel finale. Il passaggio dalla cronaca al monologo avviene con l’aiuto di una bottiglia di vino, preceduto dalla più classica delle invocazioni alla Musa: “Torna, giovinezza, torna. Parla attraverso la mia bocca”. Sylvestre, ora Silvio, affronta un corpo a corpo con il fantasma dell’antica amata, Hèléne, la quale ha sì rivelato al marito di essere madre di Brigitte, ma ha omesso il nome del suo ex amante. Quel che resta del “gondoliere” si ribella alla versione della donna (“E’ stato solo un attimo di smarrimento, poche settimane di follia, inorridisco al pensiero”). Proclama che tra loro due è stato amore, e che la vera Hèléne è la ragazza ardente e libera che lui ha conosciuto, non la copia “sbiadita e fredda, mendace quanto l’epitaffio di una tomba” che l’ha sostituita. Nel ripercorrere la breve storia della loro passione, Silvio contrappone la verità dei sensi alle falsità del logos. “Le nostre labbra si muovevano, ma non facevamo altro che mentire. Soltanto i nostri occhi si interrogavano e vicenda, e si riconoscevano. Quando la strinsi tra le braccia, le nostre labbra furono finalmente sincere.” Nel sesso avviene un riconoscimento profondo ma fugace. Quando Silvio si stacca da Hèléne dopo l’amplesso, l’ama già di meno.
È allora cos’è l’amore? La complicità, l’amicizia, la serenità divisa con la persona che si è scelta per attraversare le intemperie della vita, o il subbuglio delle viscere, gli spasmi incontrollati del desiderio? In un vecchio film di Lewis Milestone, Rain, il peccato segue traiettorie ricorsive degne di Nietzsche, si propaga come una maledizione. Qualcosa di simile accade ne Il calore del sangue, le cui simmetrie interne (alimentate dalle coppie speculari Hèléne-Colette e Sylvestre-Marc) richiamano Cime tempestose di Emily Brontë. Del resto, Marc è alto, scuro di carnagione e di capelli, bellissimo, sanguigno, un Heatcliff privo di angosce metafisiche. Ma forse l’influsso decisivo per l’ebrea Nemirovsky è stato un altro: la Bibbia. “I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati”, proclama Ezechiele. Aggravate dall’ipocrisia, le colpe dei genitori ricadono sui figli, che pretendono di emularli ignorando che la saggezza non è un dono di natura, ma una conquista faticosa, come faticosa è stata la sorte di questo libro. Concepito nel 1938, fu completato nel 1942, giusto in tempo prima che l’orrore del Terzo Reich inghiottisse, come un’acqua profonda, la scrittrice russa. Ne Il calore del sangue un presagio della catastrofe è forse possibile rintracciarlo nei meccanismi predatori che regolano il ristretto universo contadino, nello smarrimento morale degli adulti, nel trionfo di impulsi irrazionali dal chiaro intento distruttivo, che in Suite francese raggiungeranno il loro culmine scandaloso. Anche Borchard, con L’amante indegno (1929), ha scelto la via della tragedia passionale per raccontare il declino di un mondo (l’aristocrazia terriera tedesca). Nel caso di Nemirovsky, sul piatto della bilancia c’è altro.
Sul testo aleggia, forte, una componente autobiografica. Nel 1940, dopo la legiferazione antisemita di Vichy, la scrittrice e il marito raggiunsero le figlie a Issy-l’Évêque. Irène trascorse molto tempo in quell’Hôtel des Voyages in cui, nel romanzo, Sylvestre è solito giocare a carte con gli altri contadini. Molti dei personaggi di Chaleur du sang nascono dalle osservazioni quotidiane della scrittrice, che mantenne alcuni dei nomi originali. La morale del libro è in uno scambio tra Hèléne e Sylvestre. La donna chiede al vecchio amante se, di fronte a certi episodi della vita, gli capiti mai di “pensare all’instante da cui sono sorti, al germe di cui sono frutto”. Chissà quale epilogo avrebbe conosciuto la vita di Nemirovsky se, anziché inseguire le proprie ossessioni, avesse scelto di aderire al calco di una madre fatua e anaffettiva, “impietrita in una finta giovinezza a forza di creme, presunzione e avarizia” (Philipponat-Lienhardt, dalla postfazione al testo). Questo ci riporta a Il calore del sangue, a Hèléne, a Sylvestre, a Colette, a Brigitte, a Marc, a questi vecchi che coltivano il vuoto, a questi giovani che bruciano e impazziscono, sul cui destino aleggia una domanda: “se si conoscesse in anticipo il proprio raccolto, chi mai seminerebbe il proprio campo?”.
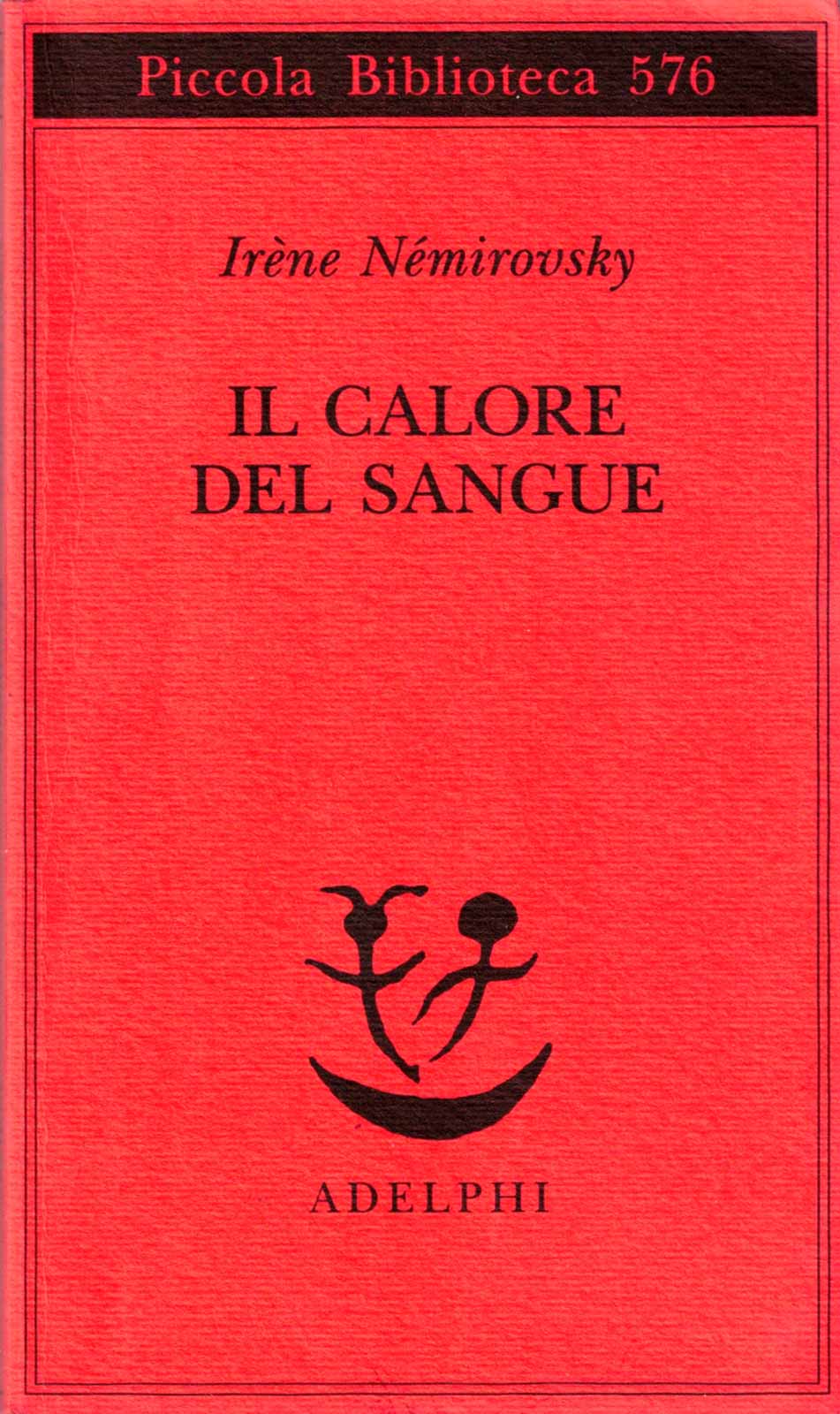
Il calore del sangue
Autore: Irène Némirovsky
Traduttore: Alessandra Berello
Editore: Adelphi
Collana: Piccola biblioteca Adelphi
Anno edizione: 2008
Pagine: 155 p., Brossura
EAN: 9788845923128
