La letteratura di Thomas Bernhard è percorsa da uno squilibrio di forze – stilistiche, psicologiche, filosofiche – che trovano nella scrittura una ricomposizione, tanto più miracolosa se si considerano l’eccentricità della forma e lo sconquasso del tessuto narrativo tipici del romanzi dello scrittore austriaco. L’epicentro di ogni cosa è un io che soccombe, inevitabilmente soccombe. Parlando, logorroicamente, questo io estromesso dalla grazia, che ha perduto i propri privilegi, prolunga fino all’estenuazione il commiato, in un sussulto di disperata vitalità. I romanzi di Thomas Bernhard sono cronache della fine nel momento in cui la fine incalza, si protende, travolge ogni cosa. L’eroe bernhardiano liquida il mondo per la disperazione di non poter essere. Sceglie la via della reclusione, della follia, del suicidio, dopo innumerevoli tentativi. Pesa, su questi insuccessi, l’assenza di orientamenti saldi. L’eredità paterna è fallimentare, corrotta. Lo splendore – se davvero c’è mai stato – è più indietro, irraggiungibile, avvolto nelle brume del mito, un geroglifico indecifrabile. Ciascuno è solo dinanzi alla spaventosa assurdità dell’esistenza, rivelata dalla brutalità e dall’insensatezza della modernità.
In Amras gli ingredienti tipici della poetica bernhardiana ci sono tutti. Anzitutto, i due fratelli, gemelli, involontari superstiti di una spaventosa tragedia famigliare, un suicidio di gruppo orchestrato per scampare ai debiti e alla malattia materna. Dopo il fattaccio, K. e Walter vengono ospitati dallo zio ad Amras, sobborgo tirolese su cui svetta una torre che diventa, come sempre in Bernhard, rifugio e prigione mortale. Entro le quattro mura dell’edificio, K. e Walter sperimentano una sorta di fusione mistica che sconfina nella catastrofe: Walter, studioso di musica, si toglie la vita.
La scrittura di Bernhard è un’architettura governata da leggi misteriose e audaci. Soprattutto, si muove lungo il crinale di uno sconcertante paradosso: negare (distruggere) la storia che racconta nel momento in cui la racconta. Amras accumula materiali assai eterogenei. In perfetto stile bernhardiano, il racconto è un resoconto. K. scrive quando il disastro è già avvenuto, intrecciando ricordi organizzati in ordine non cronologico, riflessioni, lettere (allo psichiatra, allo zio, a un vecchio professore) e appunti del fratello, talvolta ridotti a frasi o brandelli di frasi (nella prima stesura, i “logaritmi”). Come riporta il compianto Luigi Reitani nella postfazione all’edizione SE, Bernhard era stato tentato di adoperare l’espediente del manoscritto ritrovato nel tentativo di stemperare l’audacia della composizione, di giustificarne la natura frammentaria in un modo che, tuttavia, sarebbe risultato forzato e poco coerente con la sua inclinazione chiaramente terroristica, iconoclasta.
Come sottolineato dallo stesso autore, Amras allude al processo di dissoluzione di una genealogia famigliare. Sullo sfondo, la vallata di Innsbruck che, come la lugubre Weng di Gelo, è un monumento all’incontrario alla fu Austria felix, una scenografia di morte popolata di zotici, pervertiti e criminali, ostaggio della “malignità delle tempeste di föhn” e dei miasmi della “grande Storia” che rende pazzi. “Perché siamo costretti a vivere ancora?”: è la domanda che aleggia, muta, durante le lunghe ore di solitudine nella Torre. Mentre in Gelo il suicidio è evocato e puntualmente differito dal chiacchierone Strauch, che solo alla fine del romanzo si arrenderà al proprio destino, qui è il motivo cruciale, la scaturigine del testo, e addirittura concede il bis quando Walter sceglie di lanciarsi nel vuoto dalla Torre. Dei due fratelli, Walter è il più fragile, una creatura romanticamente distrutta dall’epilessia materna, che ha ereditato, e da “un sistema nervoso piuttosto bizzarro”. La Torre funge da catalizzatore, da amplificatore delle ossessioni del giovane. La sua epilessia, che Bernhard beffardamente fregia dell’aggettivo “tirolese”, si aggrava. Nell’oscurità scrosciante di Amras i due fratelli sperimentano un’esaltazione spirituale, un senso di comunione con l’Assoluto venato, però, di nichilismo (“Perturbati e messi a parte dei segreti dell’intera natura, tutt’a un tratto percepimmo la saggezza della putrefazione”). Walter e K. scoprono un’animalità felina e autodistruttiva. La dimensione simbiotica del loro rapporto allude a un’inclinazione incestuosa e omoerotica (in cui K. è chiaramente il soggetto dominante), ma soprattutto all’ideale di un sapere universale in cui scienza ed estetica risultano fuse. Il linguaggio, di colpo, risulta insufficiente. Il naturalista K. vede le proprie teorie andare in frantumi. “Il nostro modo di parlare, soprattutto quello di Walter, […] all’improvviso era diventato un linguaggio strozzato, servile, calpestato, frantumato dal panico”. Come Gelo, Amras è venato di uno scetticismo nei confronti della razionalità tecnico-scientifica cui si ricollega la polemica sottolineatura dei “martìri tipici dell’ambiente accademico, soggetto alle leggi paralizzanti del mondo dell’insegnamento” che annientano ogni vocazione creativa. Dopo il trasferimento ad Aldrans, K. scrive a un professore: “Non studio più nulla, con l’equilibrio totalmente disturbato, me ne vado per una selva di esperienze soffocate, di appigli mortali per lo spirito, tutto è morto, tutti i libri sono morti, e io non faccio che respirare un’aria morta”. Anche l’ultimo tentativo di integrazione con il mondo (grazie al lavoro manuale, di boscaiolo) ha mancato il bersaglio. L’allusione, nella lettera successiva, alle dure condizioni dei manicomi svela la triste fine di K. La missiva è indirizzata dalla fittizia Schermberg, in luogo forse della reale Schernberg (occhio alla “n”), sede di un celebre ospedale psichiatrico.
In questa “storia di un’iniziazione fallita” (Juliane Vogel), il rifiuto dell’eredità paterna – spirituale e culturale, prima che materiale – è uno dei temi centrali. I due fratelli sono i capostipiti di una genia di antieroi occupati a liquidare il passato, inteso come storia personale e bagaglio di un’intera cultura. Scrive K. di aver trascorso l’intera vita “cercando di liberarmi di me stesso e di Walter, della nostra famiglia, delle innumerevoli generazioni della nostra famiglia, cercando di liberarmene con le astuzie del corpo e della mente, invano… passando sempre da uno stato di caos all’altro… da sempre condannato a spegnermi insieme alle malattie mortali del Tirolo, alle malattie mortali della nostra famiglia… ed è così che anche Walter si è spento per via delle tante malattie mortali del Tirolo, delle malattie mortali delle nostre famiglie…” Schiacciati dall’epilessia materna, divenuta “il centro della nostra vita”, e dallo scandalo del padre che “s’era giocato e bevuto i soldi nelle belle città italiane di Mantova e Torino”, genitori e figli pianificano la propria tragica fine. La sera cruciale, prima che i quattro si ritirino nelle rispettive stanze ciascuno con una scorta di compresse sufficiente a guadagnare l’agognato oblio, si imprimono nell’immaginazione di K. i frammenti di una vita irrimediabilmente perduta ma amata, desiderata – libri, volti, mani, abiti, pensieri un tempo piacevoli a cui i quattro, viaggiatori nella sala d’attesa del proprio sprofondo, forse non sono davvero pronti a rinunciare. Walter e K. sono i tristi epigoni di un mondo al collasso, i superstiti di un ordine sociale fallimentare, opprimente, che al netto dei sogni di grandezza ha prodotto due Guerre mondiali e il Nazismo. La carica angosciosa, traumatica, del passato è esemplificata dalla particolare avversione di Walter per un coltello custodito nella cucina della Torre, coltello che Philippine Welser, moglie morganatica di Ferdinando II d’Austria, Governatore del Tirolo, avrebbe importato da Augusta donandolo, nel 1557, al marito. Walter è ossessionato dalle possibilità di infliggere, per mezzo di quel coltello, “sofferenze che altrimenti non sarebbero mai nate”. Il coltello esercita una fascinazione morbosa anche su K., che lo adopera per tagliare la carne affumicata, nutrimento in cui si riverbera “un’immagine fantastica di truppe massacrate, di culi morti, talloni teste e braccia e gambe penzolanti dal tenebroso soffitto della cucina”. A sera, K. intinge le fette di carne nel vino, deformando il sacramento cristiano dell’eucarestia in un rito cannibalico, una messa mostruosa (peraltro celebrata in una cucina “nera”) che rievoca il trauma della guerra e, insieme, la colpa sepolta di un’intera società. Welser e Ferdinando II vivevano nel castello di Ambras (occhio alla “b”), tra gli oggetti personali di Philippine si contano molteplici posate finemente decorate, ad esempio un celebre cucchiaio, ma non un coltello. Il “coltello di Augusta” è un oggetto liminale (l’altro è la spaventosa sedia da epilettico su cui Walter si accomoda durante gli incontri con l’internista), sospeso tra idealità e materialità, che realizza un interscambio tra realtà storica e letteratura. La sua lama straordinariamente affilata, impreziosita da una “cesellatura filosofica” che ritrae le torri della città di Augusta, si ricollega – mise en abyme – alla condizione di segregazione fisica ed esistenziale dei due fratelli, separati dalla famiglia, dal mondo, dalla vita, ma anche alla frantumazione del tessuto narrativo, in Amras più accentuata che nel precedente Gelo. Del resto, proprio l’episodio del coltello interrompe bruscamente le riflessioni del narratore sul taglio della carne. Bernhard, dunque, procede per strappi, ingaggia un corpo a corpo con la sua stessa scrittura, servendosi di un fitto intreccio di ripetizioni, anacoluti, ellissi e citazioni di materiali disparati sfiora il vertice estremo della dissoluzione formale rimanendo appena un passo indietro, e anzi riuscendo nell’impresa di conferire alla partitura un ritmo musicale, un andamento ipnotico. «Nel mio lavoro, se da qualche parte si formano segni di una storia, o se solo da lontano, dietro una collina di prosa, intravedo l’accenno di una storia, la abbatto. Lo stesso vale per le frasi, mi verrebbe quasi voglia di uccidere in anticipo intere frasi che potrebbero eventualmente formarsi». Una dichiarazione, questa di Bernhard, che fa il paio con l’avversione dichiarata dei due fratelli per le chiacchiere romanzesche e con la convinzione di K. secondo cui “tutta l’evoluzione è un frammento” e “l’interezza non esiste”. E allora cos’è che esiste? Solo “quel che ci ha tormentato e quel che ci tormenta”, “quel che ci ha sedotto, chi ci ha sedotto… tutto il resto, chiunque altro, per noi, non è mai esistito…”. Recita il passo di Novalis in esergo: “La natura della malattia è oscura quanto la natura della vita”. Vita e malattia sono unite dall’oscurità, le ragioni della natura sono impenetrabili. Al fondo del dolore, una notte eterna, appena punteggiata dai flebili barbagli di “un numero enorme di possibilità di esistere spaventose, che potevano significare tutto”, e invece, tristemente, non sono niente.
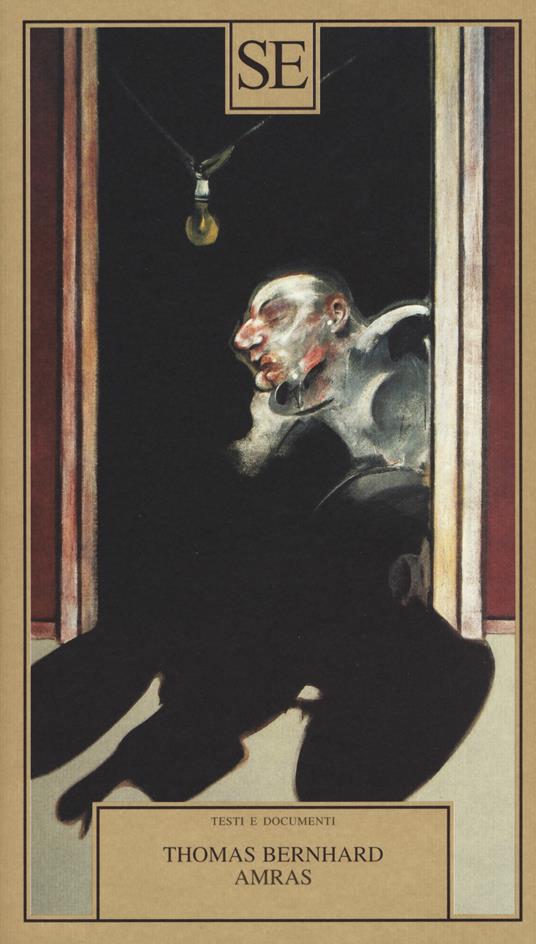
Amras
Autore: Thomas Bernhard
Traduttore: Magda Olivetti
Editore: SE
Anno edizione: 2018
Pagine: 152
EAN: 9788867233960
